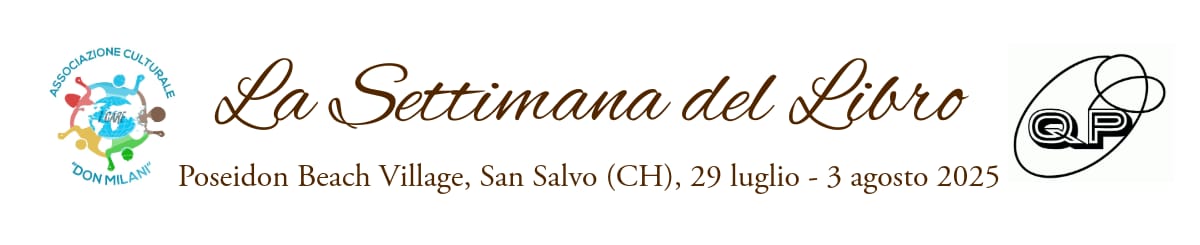Milano e Napoli, due pesi e due misure: quando l’inchiesta ha un accento
di Mario Garofalo
Se l'inchiesta urbanistica che oggi coinvolge direttamente l'amministrazione milanese, con un sindaco in carica formalmente indagato, fosse esplosa a Napoli o in qualsiasi altra città del Sud, ci troveremmo di fronte a un coro di titoli e commenti capaci di evocare, con immediatezza quasi automatica, termini come "sistema criminale", "ramificazioni mafiose", "infiltrazioni strutturali", "connivenze tra politica e malaffare". In quel caso, la narrazione si strutturerebbe attorno a una presunta patologia del territorio, a una visione perennemente emergenziale del Mezzogiorno.
Quando invece l'epicentro dello scandalo si colloca nel cuore della città-simbolo dell'efficienza lombarda, il tono si fa riflessivo, il linguaggio diventa tecnico, persino comprensivo. I fatti, che altrove avrebbero immediatamente sollevato allarmi etici e richieste di riforma, vengono in questo caso ricondotti nell'alveo di un momentaneo sfasamento amministrativo, di una crisi istituzionale da normalizzare con discrezione. I commenti si allineano su un registro pacato, e le parole più gravi lasciano spazio a letture temperate e a una certa indulgenza di fondo.
Questa differenza di trattamento non si esaurisce in una questione stilistica o comunicativa; riflette piuttosto un'abitudine sedimentata a calibrare il giudizio secondo coordinate territoriali e culturali. In alcune aree del Paese, l'illegalità viene spesso letta come tratto costitutivo e radicato, mentre in altre viene interpretata come deviazione contingente da una presunta norma virtuosa. Al Sud si cerca il sistema; al Nord si giustifica l'eccezione.
Nel caso milanese, siamo di fronte a un'indagine che coinvolge uno dei centri nevralgici del potere urbano: l'urbanistica. Si tratta di un ambito in cui non si progettano solo edifici, ma si plasmano rapporti di forza, si modellano interessi, si disegna il futuro delle città secondo logiche che intrecciano politica, finanza e visione strategica. Proprio per questo colpisce la quasi totale assenza di reazioni forti da parte di chi, in altre circostanze, ha rivendicato con decisione il primato della legalità e la necessità di una trasparenza radicale. In questa situazione, si assiste invece a una ritirata silenziosa, a un attendismo che si traduce in parole deboli e scelte interlocutorie.
La questione, tuttavia, supera la contingenza e chiama in causa una riflessione più ampia sulla coerenza delle classi dirigenti e sulla qualità del discorso pubblico. Una visione autenticamente democratica richiede l'adozione di criteri uniformi nell'interpretazione dei fatti e nell'attribuzione delle responsabilità. La legalità non può trasformarsi in principio flessibile, da evocare con forza in alcuni casi e da diluire in altri a seconda della convenienza politica o della posizione geografica. Se l'etica pubblica ha un senso, deve mantenere la sua forza anche quando coinvolge soggetti ritenuti "vicini" o culturalmente affini.
Mettere a nudo questa doppia velocità con cui vengono lette le vicende giudiziarie significa sollevare il velo su una delle ipocrisie più persistenti della narrazione nazionale. È un esercizio scomodo, certamente, ma necessario per misurare la maturità di un Paese che ambisce all'equità istituzionale e alla giustizia sociale. Restare in silenzio, o peggio ancora attenuare il giudizio, significa compromettere la credibilità stessa dell'impegno civile.
Chi ambisce a guidare processi di trasformazione sociale e culturale deve dimostrare di possedere il coraggio della responsabilità, anche quando questa comporta l'onere di guardarsi allo specchio. La legittimità non nasce dal ruolo, ma dalla capacità di agire in coerenza con i propri principi, anche — e soprattutto — nei momenti di crisi.
In definitiva, la posta in gioco va ben oltre l'esito di un'inchiesta o la parabola personale di un amministratore. Riguarda il modo in cui un'intera comunità nazionale decide di raccontarsi, e con quale onestà intellettuale sceglie di distinguere tra giustizia e opportunismo. Se si vuole costruire un Paese solido, il rigore etico non può conoscere eccezioni, né dipendere dal codice fiscale del protagonista di turno. Serve una parola pubblica che pesi sempre allo stesso modo, sotto qualsiasi latitudine e in qualsiasi accento.